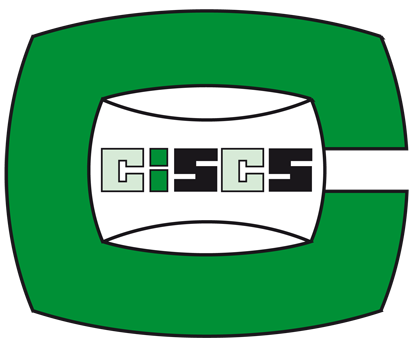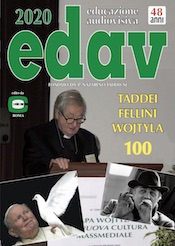CASO ENGLARO, I MASS MEDIA E QUALCOSA CHE VA OLTRE L�EUTANASIA
di LUIGI ZAFFAGNINI
Edav N: 367 - 2009
L’articolo ampliato e completo di foto, schemi si trova in Edav n. 367 febbraio 2009
Si può tranquillamente affermare che, se non ci fossero stati i massmedia, il caso Eluana Englaro non si sarebbe nemmeno posto. E con esso tutta la confusione che gli è stata creata intorno. Confusione, ben s’intenda, sul piano dei valori, come conseguenza del «mercato di opinioni», portato sempre piú spesso a scambiare il bene col male, il giusto con l’ingiusto.
La gran confusione di fondo.
Proprio perché i media traggono la linfa della loro esistenza dalla quantità di coloro che riescono a raggiungere, la confusione è una delle prime conseguenze che portano necessariamente con sé, nella rincorsa all’audience.
Anche quando si pongono l’obiettivo della imparzialità, della par condicio, della neutralità, non possono far altro che esprimere un’interpretazione soggettiva circa gli argomenti che trattano. Già solo il fatto che i media mettano sullo stesso piano valori obiettivi erga omnes e opzioni individuali, basta a far capire quanto contribuiscano all’instaurarsi di un relativismo soggettivistico e quanto poco aiutino a formare una coscienza critica. Grazie a loro anche l’etica diviene provvisoria ed esposta al vento delle mode e del numero quanti le seguono.
Tutto questo, e molto di piú, è implicito nella vicenda di Eluana Englaro. Difficilmente, però, lo si vorrà ammettere. Per farlo, bisognerà essere disposti a capire che l’invocare la libertà assoluta per ogni individuo è la negazione della convivenza civile. Non siamo certo su questa strada quando, come nel caso in questione, si qualifica la libertà nei confronti della propria vita, intendendola come disponibilità totale e non come amministrazione di un qualche cosa che (perfino in un paradossale caso di clonazione) non ci siamo procurati da soli. Siamo piuttosto di fronte a qualcosa di preoccupante. Infatti, in questo modo, viene scardinato il senso stesso della realtà, al punto che il modo di intenderla ha molto di piú del patologico che non dell’ideologico.
Non è forse sistematicamente provato che i terroristi suicidi fanno proprio un concetto di disponibilità totale della vita, che viene ritenuto patologico in se stesso, al di là di ogni principio religioso o politico e al di là del fatto che le azioni derivanti da tale concetto procurano vittime innocenti?
Comunque la si pensi su questo aspetto, resta il fatto che tutto ciò che riguarda da vicino la definizione di vita e di morte non dovrebbe essere oggetto di contrattualismo democratico (cioè stabilito da una maggioranza). Soprattutto quando ciò rischia di essere frainteso come il fissare quantitativamente lo stato di una condizione o dell’altra, al di fuori del dovuto riconoscimento in esse di un valore di sacralità qualitativa. E si badi bene: di sacralità e non di religione! Perché non è questione di fede o di appartenenza a questa o quella religione, attribuire alla vita e alla morte una dimensione qualitativa e non puramente determinabile quantitativamente in base a una scansione del tempo o della efficienza corporea.
Non è certo fuori luogo affermare che, su temi delicati quali questo, qualsiasi studente di medicina o di biologia sa perfettamente che, perfino a livello prettamente organico, non è cosí facile definire lo stato di vita e quello di morte. Anche di fronte alla infinitesima dimensione di una singola cellula, lo stato delle conoscenze scientifiche bio-mediche si arresta a una definizione funzionalistica, che cerca di definire la vita come la compresenza di funzioni biologiche elementari (nutrirsi, riprodursi, rispondere agli stimoli...). In quest’ottica la morte diviene la privazione di queste funzioni. Ma non è ancora possibile stabilire con certezza univoca quale o quali siano le funzioni che devono venire a cessare per potere definire morto un organismo. La questione, quindi, non si può ricondurre a un fatto quantitativo, perché difficilmente un organismo vivente è riducibile all’elenco delle funzioni che esplica come vivente.
L’equivoco del caso particolare.
Come sempre accade, i media, anche in quest’occasione, hanno fatto di un caso particolare uno stereotipo, cioè hanno preso come emblematica di una condizione generale una situazione specifica. Questa, per altro, proprio per la sua intrinseca caratteristica, si prestava poco a essere strumentalizzata fino al punto di diventare la frontiera tra interpretazioni politiche diametralmente opposte. Non esisteva, ad esempio, né una ventilazione forzata, né la presenza di nessun’altra macchina sostitutiva di una qualche funzione corporea.
Ma anche qui i media non hanno fatto tutto da soli, anche se si sono prestati a un gioco estremamente pericoloso per il livello stesso di civiltà cui siamo pervenuti grazie al sedimento di una lunga tradizione culturale.
Le considerazioni che seguono non serviranno certo a far riflettere i responsabili dei media, dal momento che prescindono da qualsiasi interesse di tipo economico, ma è probabile che piú di un lettore ricordi come sono stati presentati antecedenti come il caso Welby e quello di Terry Schiavo. E qualcosa, almeno dentro il mondo cattolico, dovrebbero ricordare anche tutti coloro che (religiosi o no), sui media, hanno fatto mostra di affermare il primato individualistico sul complesso dei principi etici della Chiesa cui appartengono1.
Ecco dunque che, con un po’ di lettura strutturale dell’evento e dei media, si può smascherare il fatto che il caso Englaro è stato sollevato, non per risolvere una pesante e straziante vicenda privata, ma per diventare l’apripista di un tentativo, assai poco nascosto, di provocare un ulteriore profondo cambiamento di mentalità nella società italiana in direzione nichilista. E il primo che ha permesso che tutto questo si realizzasse, quali che siano stati i suoi sentimenti, è stato indubbiamente il padre.
Infatti, cosí come nel periodo cruciale della de-alimentazione, ha scelto di non essere presente, ugualmente avrebbe potuto arrestare in qualsiasi momento la sovraesposizione mediatica cui inevitabilmente si andava incontro. Invece no. Il suo lungo accanimento alla ricerca di una sentenza giudiziaria, che coincidesse con le proprie aspettative, trova spiegazione solo se si comprende che l’obiettivo poteva essere raggiunto solo se si fosse spostato l’evento dalla sfera privata a quella pubblica e addirittura istituzionale. Pertanto le marcate sottolineature psicologico-emozionali e, da ultimo, l’appello al silenzio appaiono assai dissonanti e sono da considerare parte di una condotta strategica di quanti, oggi, post mortem di Eluana, rivendicano «un traguardo di libertà». Alla responsabilità che il padre si è assunto, va dunque aggiunta quella di una vera e propria lobby di pressione. Insieme hanno trascinato sul palcoscenico dei media anche l’ultimo ricordo di una figlia, pur di torcere il collo degli italiani a guardare solo da una parte: quella del loro punto di vista.
Dopo tante sentenze emesse in senso contrario, il traguardo è stato raggiunto in forza di un’ennesima disposizione di un Tribunale Amministrativo Regionale, che è entrato nel merito del diritto e non della procedura. Cosí si è sconfessato ogni atto (ad esempio quello della Regione Lombardia) teso a bloccare una precedente sentenza della Corte di Cassazione.
E il fatto che tanti livelli e organismi della vita pubblica e istituzionale siano stati coinvolti ha fatto emergere nella situazione un carattere di controversia, che abbandonava il territorio dell’etica per radicarsi in quello della politica. Inevitabilmente, quando a ogni decisione circa questo tipo di problemi, si fanno assumere i colori della contrapposizione politica, si spostano i termini della questione dal livello alto del bene e del giusto, eticamente intesi, al livello piú basso del bene e del giusto utilitaristicamente concepiti.
L’ottica politica diviene cosí, nelle intenzioni di chi la impone, l’unico modo ammissibile di guardare a una realtà, perché garantito dalla fede nella democrazia rappresentativa. Una volta portato il problema a tale livello, la soluzione può sfociare solo in un atto di legge. E il fine di un tale atto è sempre il prodotto di un accordo piú o meno condiviso e non in funzione del valore etico in sé.
Risparmiamoci, pertanto, ogni indagine sulla legittimità e regolarità degli atti che hanno portato a tutto questo, che ad altri spetta tale compito. Concentriamoci invece sul fatto che, mai come in questo caso, lo slogan sessantottesco «Il privato è politico» è stato confermato e tradotto in pratica con tutta la gravità delle conseguenze che comporta.
La prima di queste è l’innegabile dissolvimento del concetto di responsabilità personale, che è fondamentale nel diritto e nell’etica. Ciò si è verificato nel momento stesso in cui si è voluto che fosse una società intera, o almeno la gran parte di essa, ad avallare quella decisione che il padre aveva decretato, a suo dire, da ben diciassette anni.
In tal modo un’intera comunità sociale, fornendo il supporto delle proprie magistrature e istituzioni, ha permesso di allontanare ogni sospetto di omicidio e di suddividere tra i molti la responsabilità di un atto che, comunque lo si voglia definire, è troncante uno stato di vita, sia pur vegetativa. Colpa di tutti, quindi di nessuno.
E a questo proposito non può sfuggire che, anche sotto il profilo antropologico, questa vicenda fa cogliere appieno il carattere sacrificale della vittima a fronte di una presunta conquista, per molti, di un principio di libertà decisionale in materia di morte. In una parola: «un vantaggio per tanti val bene una vittima».
E qui, allora, deve per forza iniziare un terzo livello di considerazioni che faccia capire quanto questa politica di portare tanto in là la difesa della supremazia delle formulazioni concettuali astratte (i diritti, la legge, le istituzioni, le procedure, la libertà, ecc.) rispetto alla pura e semplice realtà, ha prodotto d’irreparabile nella capacità di un popolo di mostrarsi equilibrato nelle scelte etiche. D’ora innanzi, infatti, sarà lecito identificare la morale come la sommatoria delle aspettative individuali, ormai sempre piú frequentemente avallabili da sentenza amministrativa, piuttosto che come valore obiettivo. Un punto in piú segnato dal relativismo imperante.
E in questo contesto, allora, non è fuori luogo vedere il tutto come un regresso della coscienza civile di tutti quegli italiani, che si sono accodati alla richiesta di togliere acqua e cibo. Essi si trovano nella precisa condizione di cittadini pre-sociali che, avendo messo in crisi il riferimento a precetti sicuri e indiscutibili, ma onerosi da rispettare, sono incapaci di trovare l’energia per reggere alla drammaticità di una situazione. Uniscono, perciò, le loro volontà in un atto di atrocità collettiva, contro l’elemento piú debole, per impedire che la violenza, insita nell’umana natura, si scateni all’interno del loro ambiente, compromettendone la stabilità e il quieto vivere.
Il paradosso, l’assurdo e il ribaltamento di significato.
«Si conferma [con la sentenza del TAR (n.d.r.)] che la magistratura italiana è molto piú sensibile e attenta alle ragioni del diritto, della legge, oltre che della misericordia e del senso buono».
Questo passo della dichiarazione, rilasciata a suo tempo a Radio Radicale da una deputata radicale2, assertrice della «bontà» dell’atto di togliere acqua e cibo a Eluana, aiuta molto a sgombrare il campo da dubbi sulla reale natura del grande meccanismo messo in moto e sulla forma mentis di quanti lo hanno alimentato. Essi, sentendosi padroni di definire a proprio piacimento cosa sono la legalità e la sensibilità umana, sono scesi in campo con vere e proprie dichiarazioni di guerra all’intelligenza. Convinti che essere progrediti, tolleranti e addirittura misericordiosi, voglia dire, prima di tutto, combattere i valori di stampo cattolico, visti come un’imposizione, hanno invocato l’eutanasia e hanno enfatizzato tutti gli aspetti che possono far slittare una legge sul termine vita verso questo obiettivo. Cosí facendo, hanno optato, paradossalmente, per una forma di oscurantismo intellettuale, che contrasta fortemente con il loro dichiarato desiderio di progresso, di modernità, di tolleranza e addirittura di misericordia.
Il cattolicesimo e il cristianesimo c’entrano poco in tutto questo, se non per il fatto che gli uomini di chiesa e i credenti non potevano far altro che ribadire ciò che è parte integrante e irrinunciabile del loro patrimonio di fede e che non potrebbe essere diverso da quello della difesa della vita e della dignità della persona, conformemente a quanto sta nel Vangelo.
Il torto, se cosí si può dire, non è stato fatto soltanto ai principi cristiani, che legittimamente si possono rifiutare, quanto piuttosto alla logica e al significato delle parole che sono stati stravolti. Un’ondata di ideologizzazione e, come al solito in Italia, di anticlericalismo, hanno preso il posto di un equilibrato accertamento della realtà.
Ancora una volta di piú si è voluto stabilire il primato delle teorizzazioni sulla realtà delle condizioni di fatto e, conseguentemente, si è arrivati a piegare la natura (che avrebbe fatto comunque il suo corso) alla decretazione di un tribunale. Questo, infatti, è stato sollecitato dalle istanze burocratiche di uomini (padre, avvocati, sostenitori e gran parte dei media), che si sono appellati a una copertura di «legge» per ottenere il raggiungimento del loro obiettivo: far passare la condizione di uno stato corporeo di una persona umana respirante, nutrito, potenzialmente riproduttivo, in uno stato definitivamente sotterrabile o comunque sottratto alla pietà di chi lo aveva accudito e avrebbe potuto e voluto continuare a farlo. E tutto questo in nome della misericordia. Quale ribaltamento e manipolazione del linguaggio! Tanto piú perseguiti, adducendo lo strazio, la pietà, il dolore, l’umana comprensione! La pretesa, poi, di definire, di fatto, la misericordia come un sentimento che consente di alleggerire i vivi della responsabilità verso i moribondi, sarebbe da mettere in discussione, prima che sotto il profilo morale, sotto quello etimologico e sotto quello logico.
L’emotività e il sentimentalismo, dunque, sono stati l’arma utilizzata per perseguire un risultato disumano, perché ammantato proprio di principi radicati nella cultura del dolore e della carità, ma utilizzati per ottenere uno scopo diametralmente opposto. Se questa non è astuzia, si dica allora, almeno, che è superficialità, che ha tutte le pretese di essere gabellata per onestà intellettuale. Gabellata, al punto da voler assurgere a principio etico che, per essere riconosciuto, ha necessità di coinvolgere l’ordinamento giuridico di uno stato e le sue cariche istituzionali, in nome della tutela dei diritti costituzionali del cittadino.
Ma non c’è da scandalizzarsi troppo, perché non potrebbe essere diversamente in una società che, nella sua veste politica e istituzionale di stato democratico, accorda ogni garanzia ai colpevoli e assicura, purtroppo, agli innocenti, agli impossibilitati a far udire la propria voce, un trattamento ben diverso. Uno dei tanti paradossi riscontrabili in frangenti di questo tipo!
E paradossale è il caso di Eluana. Quali colpe ha avuto? Forse quella di aver procurato strazio ai suoi genitori? Forse quella di non avere piú, dopo diciassette anni, quelle splendide fattezze che la connotavano nella fioritura della sua gioventú? Forse quella di pesare troppo sulla comunità? Forse quella di ricordare, con la sua presenza in quello stato, l’effimera condizione di transeunte dell’essere umano? O forse quella di non poter segnalare in modo comprensibile che quell’acqua e quel cibo liquido, somministrati dall’esterno, non potevano essere scambiati per accanimento terapeutico?
Forse, forse.... Quanto si potrebbe continuare! Ma in ognuna di queste domande esiste una pressante richiesta di interpellare la propria coscienza per coloro che parlano di libertà ed evitano di dar voce all’ultimo e piú tremendo dubbio: – Come possiamo dall’esterno e con le attuali limitazioni della scienza essere certi che una qualsiasi forma di consapevolezza percettiva non alberghi in quel corpo, che pur mantiene tante funzioni e che chiede solo qualche minima risorsa di liquido. Come possiamo, noi, che inalberiamo la discutibile e discussa affermazione verbale di una allora bella ventenne al rango di sentenza, sostituirci oggi alla sua singolarità identitaria, per decretare l’inesistenza assoluta di ogni possibilità che quel complesso di cellule, ancora armonicamente funzionanti in tutto, tranne che nella coscienza (per noi) della comunicazione con l’esterno secondo i canali che sono abituali per tutti, sia da defraudare del nome e del diritto di persona, se non siamo in grado di esperire una via che ci permetta di entrare reciprocamente in contatto?
Se non ci si è posti nemmeno uno di questi e di altri simili interrogativi, in cui, ripeto, la religione cattolica c’entra poco, allora diviene obbligatorio andare oltre, alla ricerca del perché Eluana, come ha dichiarato un senatore nella seduta che si teneva proprio il 9 febbraio: «... è stata ammazzata legalmente e in nome del popolo italiano»3.
L’espressione è indubbiamente molto forte e, forse, non coglie appieno proprio tutte le sfumature di un dramma, ma ha il merito di non nascondere che il livello toccato dalla questione implica considerazioni che devono andare oltre «il mercato delle opinioni».
L’altra religione.
Conviene allora riflettere che non è la prima volta che le istituzioni e la politica in Italia si occupano di vita e di morte e che antepongono una concezione meramente astratta del loro ruolo. Ciò è già accaduto con il caso Moro, nel corso degli anni settanta del secolo scorso. Pur senza giungere a decretazioni o disegni di legge, istituzioni e forze politiche contribuirono, per una cosiddetta «politica della fermezza», alla morte dello statista. Moro, infatti, era ostaggio delle Brigate Rosse, che intendevano farne oggetto di scambio con altri brigatisti in mano allo Stato. Allora si disse di no in nome della democrazia e della non volontà di riconoscere a una banda terrorista il diritto di trattare alla pari con le istituzioni dello Stato. Venne cosí, de facto, attribuito al concetto di Stato e ai principi astratti che lo reggevano un valore superiore a quello della vita di un uomo. Ma, sia detto per inciso, tale fermezza è poi sempre stata applicata in vicende successive, relative ad esempio a sequestri avvenuti in Medio Oriente?
Oggi, comunque, è accaduto qualcosa, se possibile, di ancor piú devastante dal punto di vista culturale di quanto accadde allora, anche perché questa volta, le stesse istituzioni si sono divise fino a fronteggiarsi in nome della legittimità costituzionale degli atti, pro e contro la vita. La vita in questione non è quella di uno statista, ma la filosofia che ha ispirato tutto uno schieramento, come oggi si tende a dire «trasversale», è la medesima di quella che allora faceva appellare i politici al principio de «Lo Stato prima di tutto». Solo che oggi vi si aggiunge un elemento nuovo: quello che riguarda l’attribuzione di una specificità teologico–sacrale alla concezione dello Stato, anche là dove entrano in campo aspetti squisitamente privati, legati a una concezione etica della vita e della morte delle singole persone.
La posta in gioco è altissima e l’obiettivo è molto diverso. Non si tratta, cioè, di discutere, come ai tempi del caso Moro, il sacrificio di un uomo in un momento di guerra a tutti gli effetti. Si tratta di provocare un conflitto di coscienza nel singolo cittadino, perché giunga a sostituire il concetto di vita con il concetto di libertà decisionale e il concetto di morte con quello di indegnità di vita. E, se ben si considera il tutto, il primo scambio di concetti punta al massimo del soggettivismo, per illudere l’individuo di essere padrone del suo destino. Il secondo scambio riconosce di fatto che il tipo di cultura, seguito dalla maggioranza, è il solo parametro valido per stabilire quale sia o non sia una vita degna di essere vissuta. Poiché, dunque, il nostro orizzonte è quello di una cultura massmediale, che impregna piú o meno la mentalità di tanti italiani, saranno allora i principi di questa a determinare il livello oltre il quale non si può piú parlare di vita degna. E lasciamo immaginare, allora, in base a quali modelli o pareri! Forse quelli di qualche personaggio di talk show o di qualche reality!
Anche nel progressivo slittamento di tutta una società verso questo traguardo si fatica a comprendere dove stia tutta la modernità delle conquiste umanitarie di questa nostra civiltà, rispetto alle società primitive, che condannavano i piú deboli a morire abbandonati, quando non erano piú in grado di provvedere a se stessi. E non si dica che alla base di queste concezioni non ci sono anche l’eugenetica e la filosofia della preservazione di uno stadio di cultura di hitleriana memoria. Se ne potrebbe concludere, pertanto che, in questa libido definiendi (spasmodico desiderio di definire) di coloro che ambiscono a fissare quando la vita è indegna di essere vissuta, si nasconde l’inconsapevole attrazione nell’orbita del pensiero totalitario, padre ben noto di ogni tragedia storicamente incarnata nello Stato Etico.
Ma, proprio perché chi ha messo in moto questo meccanismo desidera che l’individuo non si ponga questi problemi e non abbia il sospetto che questa mutazione etica è un’imposizione, o un arbitrio, occorre che faccia avvertire al cittadino il richiamo fortissimo di una giustizia superiore, che gli garantisca che ciò che pensa in proposito non è in contraddizione con quanto vogliono gli altri. Non potendo, nella visione laicista, questa giustizia superiore essere attribuibile a un Dio di stampo trascendente, deve per forza incarnarsi nella immanenza delle istituzioni o nella comunità sociale. A questo punto il cittadino, che voglia appartenere a un corpo sociale compatto, non potrà avere altro atteggiamento verso le istituzioni e verso l’ideologia, che sorregge la comunità, che quello di un incondizionato sentimento di fiducia in un assetto astratto (lo Stato nella sua forma istituzionale), da innalzare al disopra dei singoli.
In tale atteggiamento fideistico non c’è nulla di diverso da quello che anima il mondo dei cristiani e dei cattolici, salvo i riti differenti e i contenuti di fede.
Ecco allora che si capisce come una questione che riguarda aspetti di vita e di morte diventi un oggetto non tanto della politica, quanto di un modo nuovo di intendere la religione come un fatto relativo alla propria sfera soggettiva e orientato a sacralizzare entità non piú metafisiche, ma umanamente derivate, come lo Stato, la Costituzione, le leggi, la Patria, ecc..
Di qui lo spostamento del caso Englaro dalla sfera di un’etica, che potrebbe benissimo essere equilibrata e rispettata tanto da cattolici quanto da non cattolici, alla sfera della religiosità che richiede una trasposizione sul piano di una «fede laicista». E allora si richiede non piú la fede nei principi cristiani, ma la fede nei principi laicisti e si prospettano i dettati di una magistratura o di una legge come valori in cui credere, anche quando appaiono in logico contrasto con la realtà, che finisce, cosí, per aver meno importanza di essi.
Il vero volto del caso Englaro, che porti o no alla definizione di una legge su questa materia, è quello di un’evidente prova di forza, a lungo preparata e sostenuta, per collocare i termini vita e morte all’interno di una visione tutt’altro che laica, bensí religiosa, ma diversa da quella cristiana. Si tratta di una visione di Religio civilis,che anche i non cattolici hanno dimostrato, paradossalmente, di essere ben disposti ad accettare come religione. Ad essi basta illudersi che la patente di laici si può contemporaneamente conservare, continuando a scendere in piazza, in difesa di presunti attentati alla Costituzione repubblicana. Una sorta, quindi, di strana e contraddittoria dissociazione tra un atteggiamento di fede incondizionata nei valori della Religio civilis, anziché in quelli della religione tradizionale, e un comportamento politico spregiudicato, che pretende di difendere sulle piazze, come baluardo del laicismo, proprio gli oggetti-simbolo di una nuova religione.
Metà di questo percorso, orientato alla «conversione forzata» di un’intera società, è stato fatto con la legge sull’aborto; se l’altra metà si compirà, potremo stabilirlo quando avremo una legge sul termine della vita. Auguriamoci, però, che tale legge non consenta di camuffare un’eutanasia sotto le vesti di testamento biologico e auguriamoci che non ci sia piú alcun magistrato col potere di definire cosa è morte e cosa non lo è. Auguriamoci, infine, che tutto questo avvenga non sotto il segno della «Dea Ragione», che segnerebbe davvero il massimo della regressione storica.
Quanto poi alla Costituzione, oggetto di tanta premura, essa non può essere né monopolizzata per fini ideologici di parte, né travisata e intesa come valore di fede da venerare ancor piú della vita e della morte stesse. E, in ogni caso, la Carta Costituzionale non contiene certo assunti e principi che legittimino l’estensione diffusa di «soluzioni finali» come quelle volute per Eluana Englaro.
NOTE
1 Al proposito si ricorda l’appello di oltre 200 teologi, comparso il 31 luglio 1968 sul New York Times, che invitava i cattolici a disubbidire all’enciclica pontificia Humanae Vitae.
2 Maria Antonietta Farina Coscioni, dichiarazione del 26/1/09.
3 Gaetano Quagliariello