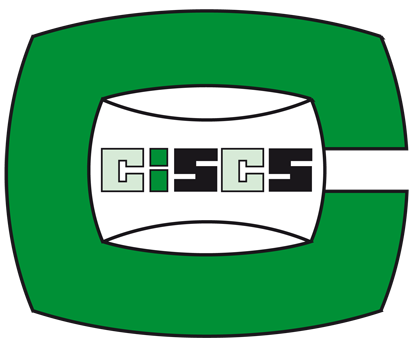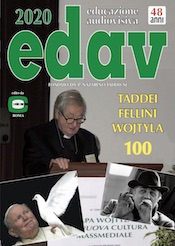Il Festival del cinema africano: cos� l'Africa si affaccia in Italia
di MICHELE SERRA
Edav N: 352 - 2007
Il festival del cinema africano che da 17 anni si tiene a Milano è uno di quei festival piccoli ma specializzati, che non si disperdono in mille direzioni sul cinema di tutto il mondo e ne fanno un mercato, una fiera, dove i prodotti vengono messi in vendita per essere poi proiettati nelle sale pubbliche. Sono, i piccoli festival, piú interessanti, perché approfondiscono e concentrano l’attenzione in una sola direzione permettendo di conoscere un particolare aspetto del mondo del cinema: una corrente o un’epoca o il cinema di un regista, di modo che, alla fine, avete una tessera sostanziosa del mosaico che compone l’intero mondo cinematografico.
La Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia, quella di Cannes, quella di Berlino, per nominare le tre piú famose, sono forse vivaci da un punto di vista mondano, attirano curiosi, sono reclamizzate dalla stampa perché costituiscono un avvenimento con notevoli risvolti economici e divistici; si tratta qui di mettere in mostra i prodotti di un’industria e se anche qualcuno di questi festival dice di cercare l’arte, questa viene spesso negata dai fatti e dall’esile spazio che il commercio cinematografico le riserva.
A Milano invece il festival non si isola in una campana di vetro riservata soprattutto ai divi e agli addetti ai lavori (produttori, distributori, noleggiatori); qui vi partecipa attivamente, intensamente, il pubblico cittadino, che si aggiunge a quello veramente interessato che giunge un po’ dappertutto, dalla Sicilia come dal Veneto, da Roma come da Genova e vi si incontrano giovani che vogliono conoscere opere e contenuti di altri continenti, quelli che generalmente non sono al centro del cinema cosiddetto occidentale; preparano tesi di laurea, cercano colloqui con cineasti che certamente non troverebbero nei grandi festival, dove, anche se ci fossero, sarebbero immersi in un clima di distrazione e da fiera.
Il pubblico della città è sempre quantitativamente e qualitativamente presente e si percepisce questa seconda caratteristica dall’entusiasmo e dall’atteggiamento critico con cui si accosta a ogni film succhiandone avidamente informazioni, sentimenti, modi di fare e di parlare, gioie e sofferenze.
Si spazia, a Milano, tra film che giungono dall’Africa Nera, quella subsahariana, all’Africa del Nord, il cosiddetto Maghreb, e all’»Africa della Diaspora», a quei film realizzati da africani che ormai, magari da varie generazioni, risiedono in altre parti del mondo soprattutto negli Stati Uniti d’America dove forte fu la deportazione di schiavi.
Per dare un’idea di che cos’è il cinema africano oggi, quello che ormai ha superato i complessi di inferiorità rispetto al cinema occidentale, dove la tecnica evidentemente è assai sviluppata e dove il denaro fa la differenza (tecnica, non contenutistica; questa dipende da altri fattori!), presento alcuni di essi, citando in particolare o dei veri e propri capolavori magari non reperibili in Italia, ma solo in altre nazioni europee in DVD, oppure quei pochi film che hanno avuto privilegiato accesso al nostro mercato interno e quindi, pur con vita breve, trovano ospitalità sui nostri provinciali schermi italiani.
Africa del Nord
Un film assai serio e interessante, drammatico, si chiama, La Petite Jerusalem. Parla di ebrei che vivono in stretta comunità alla periferia di Parigi, in un quartiere chiamato Piccola Gerusalemme, anche se ufficialmente il sobborgo è quello di Sarcelles.
Il regista ci porta all’interno e intorno ad una famiglia e indaga nei pensieri e nei comportamenti delle due donne che la abitano, due sorelle, una maritata ad un uomo assai religioso e l’altra studentessa di filosofia, materia in cui cerca la sua realizzazione psicologica e l’indirizzo da dare alla sua vita. Le religione porta a vivere drammaticamente problematiche sessuali nel matrimonio, la filosofia pare invece che accolga i propri criteri di vita da un’impostazione severa dell’esistenza. Eppure la storia non segue strade rette come uno se le prefigura e ad aiutare a dipanare dubbi, rifiuti, difficoltà, la comunità israelita mette a disposizione delle donne una … – come potremo chiamarla? – una psicologa, o guaritrice, o consigliera, che con dolci carezze e con pacati consigli espressi senza pudori ma con grande naturalezza, sa infondere sicurezza lí dove invece si vedeva solo la presenza dello scrupolo, dell’ansia e del peccato, dell’astinenza e del rifiuto. Il film è di un regista di famiglia ebraica, Karin Albou e la produzione è francese e maghrebina.
Non è un capolavoro in senso assoluto, ma certamente un film girato con dignità e che comunque non sfigurerebbero sui nostri schermi. Si tratta di Barakat, di una brava e coraggiosa regista algerina, Djamila Sahraoui nata e residente ad Algeri.
Siamo nel malinconico scenario del terrorismo fondamentalista. Una donna medico si mette alla ricerca del marito giornalista, improvvisamente scomparso. Assieme ad un’ex combattente della resistenza contro il colonialismo francese parte, su indicazione di un vicino di casa, verso un sito impervio dell’interno del Paese. Qui non c’è il marito, ma si trova nella necessità di curare le ferite di uno dei caporioni dei fanatici terroristi e a patire paura, rabbia e pene che comunque le permetteranno di tornare a casa pur con fatica e grandi rischi. Scoprirà solo ora che il vicino di casa era lui a tenere prigioniero il marito e potrà liberarlo.
Interessante è assistere al confronto tra due generazioni di resistenti, la giovane dottoressa e la piú anziana compagna d’avventura. Il loro rapporto è teso, duro, la sfiducia detta il brusco sospettoso comportamento della giovane, che ritiene la compagna una spia al servizio dei terroristi. In un clima come quello dell’Algeria che sopravvive anche ai nostri giorni non è facile coltivare sentimenti di fiducia reciproca e ci vorrà del tempo per chiudere piaghe e sensi di vendetta frutto di una lotta sanguinosa e crudele non ancora spenta. Ma ora,barakat, basta!
Ancora in Algeria nasce un film importante, chiaro nel suo compito di spiegare quanto è avvenuto negli anni appena trascorsi in quel tormentato Paese. La storia è impostata su tre giovani allegri e intellettualmente vivaci che vivono ad Algeri: Asma, Fawzi e Ramdane.
Il film si chiama El Manara, che in arabo vuol dire il faro, la luce che guida le navi dentro al porto e infonde sicurezza ai naviganti. Il regista, uomo di cultura e capace di intraprendere approfondite ricerche sia attraverso il cinema che con lo studio, è Belkacem Hadjadj.
Ambienta la vicenda nel periodo delle celebrazioni di El Manara, con cui si ricorda la nascita del Profeta. Sulle modalità dei festeggiamenti, non tutti i musulmani la pensano allo stesso modo ed un gruppo di essi è particolarmente offeso dalla maniera paganeggiante con cui ormai questa solennità viene celebrata. È l’inizio di una tragedia per l’Algeria, siamo tra il 1988 e il 2004: i movimenti piú integralisti non possono accettare che certi momenti sacri della religione subiscano revisioni e comportamenti definiti osceni e reagiscono in maniera terroristica e crudele verso i connazionali che non vivono l’Islam in maniera assolutamente ortodossa. In realtà, piú che di ortodossia si deve parlare di fanatismo, di imposizione nella vita quotidiana di modi, abbigliamento, pratiche religiose, che se non accettate con convinzione, devono essere assolutamente imposte pena lo sgozzamento.
Nel 1991 nasce il F.I.S. il partito degli integralisti. Opera clandestinamente ma in maniera feroce e diffonde angoscia e paura.
I tre giovani sono concordi nell’opporsi a questo movimento, che si insinua anche nelle famiglie, divide i parenti, in nome di Dio si ammazzano i trasgressori delle regole che, affermano, sono imposte senza riserve dal Corano.
Anche fra i tre amici penetra questo crudele piano di restaurazione di un’ortodossia deviata, tanto da trovarsi un giorno su due fronti opposti.
Non si capisce piú niente, la paura dilaga, la sofferenza e il terrore pervadono gli animi, si confondono gli ideali, si disgregano famiglie, amicizie, vite. È annientato il principio di tolleranza, l’islamismo si oppone col terrore alla democrazia, non si cerchino interpretazioni del Corano, che va rispettato e seguito come legge e come stile di vita.
Hadjadj riprende cosí la memoria del suo Paese con questo film emozionante, coraggioso e «necessario», visto che pochi, almeno in Europa, hanno capito cosa succedeva (e non è finita) in Algeria nei vicini anni trascorsi e anche, però, nel mondo dove l’Islam non concede tranquillità e segni di tolleranza.
Il regista quindi vuole con questa sua opera coinvolgente proporre una riflessione per immagini e ricostruire l’identità culturale del suo Paese.
Nel Paese vicino, l’Egitto, un’altra donna fa la sua battaglia contro l’emarginazione delle donne; è Dounia, che si dedica alla danza orientale, arte in cui eccelleva la madre. Dounia è anche il titolo del film girato con vera maestria e serietà da Jocelyne Saab. Il sottotitolo continua: Kiss me not on my Eyes (Non baciarmi sugli occhi). Dounia non è certo compresa e accettata dall’ambiente, ma lei intrepida continua a frequentare la scuola di danza con l’appoggio morale e completo solamente di Beshir, un poeta sufi e docente universitario di lettere, che subirà un attentato che lo renderà cieco.
Cinema d’impegno, dunque, che fiorisce un po’ dovunque dove ci sono irrisolti problemi di libertà e di rispetto delle diverse scelte che ogni uomo deve essere libero di fare e dove la donna è meno stimata che altrove.
Tornando in Algeria, veniamo condotti da Mohamed Chouikh in un villaggio di donne – Douar des femmes è il titolo originale – dove queste sono lasciate a difendere le case, gli anziani e i bambini dall’aggressione dei terroristi mentre gli uomini stanno lavorando a chilometri di distanza. È una commedia allusiva, divertente e intrigante di schietto sapore femminista, dove comunque anche agli uomini è lasciato spazio d’intelligenza e di buon senso e dove il matrimonio è cercato ancora come valore e mezzo per completare la propria vita. Chi conosceva il regista come persona impegnata in una lotta culturale contro le piú grette, crudeli e arcaiche tradizioni (El Kaala – la cittadelle, Youcef, L’arche du desert sono i suoi film da battaglia), può dimostrarsi deluso dalla leggerezza del film, dal quale tuttavia si può trarre vantaggio culturale e anche divertimento.
L’ambiguità del linguaggio cinematografico - Making of
Il (secondo me) controverso film del «maestro» tunisino Nourd Bouzid, Making of, è stato apprezzato da pubblico e critici nel 2007, quasi a volergli attribuire un riconoscimento alla carriera. Anche a me è sempre piaciuto per la forza con cui tratteggia temi e personaggi questo simpatico e aggressivo autore tunisino. Ha sempre agito con chiarezza al di fuori di ambiguità espressive che comunque fanno parte dell’arte e della comunicazione umana.
Questa volta però ho trovato qualcosa che non mi ha convinto nel suo descrivere l’iniziazione di un vivace allegro giovane, che aspirava di diventare un ballerino, alla fede dei fondamentalisti, che pretendono una applicazione integrale e assai personalizzata in termini restrittivi e estremistici della legge coranica. Lui che fino al giorno prima era tenuto d’occhio dalla polizia perché furfantello astuto e capobanda, lontano da qualsiasi tipo di ideologia politica e religiosa e piuttosto sempre disposto a vivere situazioni di spensieratezza, improvvisamente diventa centro d’attenzione per una «cellula» fondamentalista che lo vuole ingaggiare come martire kamikaze dopo una dovuta e necessaria scuola di carattere, una vera iniziazione attraverso l’adesione a severi regolamenti, a privazioni e convinzioni a cui mai era stato abituato.
Il «catechista» che in segreto lo ospita in casa, ora che il giovane deve tagliare con la vecchia vita disordinata e senza valori condotta fino ad allora, lo segue con amorevolezza e forte controllo, sa convincere, sa riempirgli la testa di dedizione all’eroismo che, se lo porterà alla morte sacrificale, gli farà guadagnare eterna riconoscenza dei veri musulmani e un posto privilegiato in paradiso.
Beh, in realtà ci sono sussulti di coscienza che gli fanno capire che la sua vita ora sarà ristretta dentro alla volontà altrui, che è difficile tagliare con la fidanzata, la madre e l’intera sua famiglia, che qualcosa merita ripensamenti e ribellione.
Cinematograficamente la sua coscienza si esprime attraverso la discussione incalzante col regista stesso: in «insert» presentati con immagini «virate» per dar loro un significato di riflessione e di costruzione dell’intero film in accordo col protagonista – i due discutono appunto come delineare carattere e vicende successive del personaggio che il giovane sta interpretando – Bouzid cerca di fargli considerare quanto siano fanatismo smodato e criminale le proposte che gli vengono dalla cellula terroristica. Sono due o tre brevi sequenze «making of», girate da Bouzid con colori sbiaditi, «virati» appunto rispetto al resto del film, quasi a voler forse inconsapevolmente sottolineare che le sue motivazioni per far desistere il giovane dall’infatuazione in cui stava cadendo erano scarsamente suggestive e convincenti rispetto alle parole e al comportamento di chi lo sta iniziando al martirio. Infatti la storia della vita e della preparazione del giovane Bahta è condotta con colore, vivacità e sensibilità notevoli e quindi sul piano emotivo è maggiormente efficace.
So qualcosa di Nouri Bouzid e anche di un suo passato di lotta politica che, se ben ricordo, lo portò in prigione. Dubito quindi che il suo pensiero rispetto al fondamentalismo si possa assoggettare a critica, ma spesso nell’opera d’arte, libera e intuitiva espressione del pensiero, può capitare che si liberino forze, dubbi e perplessità tenute represse nel piú profondo inconscio. Nel film potremmo avere assistito ad una di queste liberazioni di pensiero represso che si manifestano attraverso un peso maggiore a livello espressivo della storia rispetto agli insert di coscienza certo piú faticosi e dialetticamente difficili da svolgere.
Insomma, il film di Nouri Bouzid è complesso ed in esso a mio parere sono presenti fondamentali ambiguità proprie del linguaggio, in particolare di quello cinematografico. Le immagini elaborate, complete, definite, che costituiscono la storia narrata dal film sono quelle piú realistiche e persuasive, mentre quelle «in controcampo» in cui viene rappresentato il regista al lavoro nella costruzione del film stesso, hanno il limite di un controcatechismo fatto con scialbore pur volendo essere la coscienza positiva del giovane Bahta.
A pensarci bene i discorsi del maestro di terrore sono certamente condivisibili da molta parte della gente oltre che da tutti i fondamentalisti a qualsiasi religione appartengano, perché egli parla di purezza, pulizia dei pensieri e dei comportamenti, di ribellione a un’idea di globalismo smodato e selvaggio e di fedeltà alla legge di Dio. Credo che questo film possa piacere ai fondamentalisti arabi e anche a tutti coloro che aspirano a una rinascita della coscienza che deve insorgere contro la corruzione del mondo moderno.
Per tutto questo, non so quanto sia auspicabile che tanti giovani vedano Making Of come auspica il regista; il film rimane prigioniero di una certa ambiguità e quindi potrebbe agire a livello subliminale nelle coscienze degli spettatori soprattutto dei piú giovani e meno attenti al linguaggio cinematografico. Ma è possibile che queste mie valutazioni siano viste come espressioni folli e ingiustificate. Sarei felice se fosse cosí e se quindi avessi sbagliato la mia lettura dell’opera di Nouri.
Stupendo, «catechistico», un esempio di fede vissuta nel rito del pellegrinaggio da parte di un anziano marocchino emigrato in Francia, un esempio sofferto ma reale di «gap» generazionale (padre e figlio convivono ma si distanziano vicendevolmente di fronte ai grandi temi della vita), un viaggio alla Mecca interminabile, pericoloso, faticosissimo sia per il vecchio padre sia per il figlio ventenne «costretto» al pellegrinaggio perché l’unico della famiglia in grado di guidare l’auto per il lungo viaggio di oltre 5 mila chilometri.
Il film realizzato dal bravo regista marocchino, il quarantenne Ismael Ferroukhi, s’intitolaIl grande viaggio e ha coinvolto assai vivamente il pubblico studentesco presente ad una proiezione speciale al Centro San Fedele.
Si narra appunto nell’incalzante film della decisione del vecchio marocchino emigrato tanti anni prima in Francia a intraprendere quel viaggio alla Mecca che è un segno di fede fondamentale per un musulmano devoto. I figli, nati e educati in terra per loro fattasi madre dal primo vagito, non lo sono per niente: lo spirito laico li avvolge del tutto e Reda adduce tutte le scuse possibili per non mettersi alla guida dell’auto per il pellegrinaggio; fra l’altro tra qualche mese deve affrontare gli esami di maturità e poi ha una ragazza che non vuole lasciare per un bel po’ di tempo.
Ma in casa non è venuta meno l’autorità paterna e quindi Reda s’appresta ad essere l’accompagnatore pur recalcitrante del padre.
Il pellegrinaggio non è un viaggio turistico, per cui le divergenze tra i due iniziano quasi subito, perché il padre non si vuole fermare per una breve visita a Milano, non lo vuol fare neppure per permettere al figlio di scattare qualche foto a Venezia, altra città sul loro itinerario, e poi s’inoltrano nella piú difficile Yugoslavia, dove le strade si stringono, i paesi diradano, la lingua diviene incomprensibile. Si soffre la fame, il freddo e il sonno quando non si trovano alberghi lungo la via ed è giocoforza dormire qualche volta in auto. Ma perché, osserva il figlio, non prendere il meno problematico aereo? In poco tempo tutto si risolveva e senza fatica.
Il padre allora racconta: un pellegrinaggio è un viaggio particolare e deve avere i suoi tempi per essere efficace. L’acqua del mare, quando evapora, sale verso il cielo e nel suo percorso ascensionale si depura, perde il contenuto salino e si alleggerisce. Cosí deve avvenire per chi intraprende il pellegrinaggio alla Mecca. Il pellegrinaggio dovrebbe essere fatto a piedi per dar tempo al pellegrino di godere di tutti i benefici spirituali. Se non si può a piedi, allora va bene anche a cavallo; se non si può, si vada in macchina; se anche questa condizione non è attuabile, si prenda la nave e solo come ultima possibilità si salga sull’aereo.
Dopo un estenuante viaggio avventuroso e ricco di sorprese piú o meno buone – fra l’altro vengono raggirati da un turco a Istanbul e lasciati senza denaro – s’arriva in vista della Mecca e lí, come succede per i tanti rivoli e torrenti che formano il fiume, ci si incontra con altri pellegrini provenienti da ogni parte del mondo e si procede in lunga processione di auto e roulotte fino alla Città Santa.
Il figlio osserva e lentamente viene conquistato dalla forte spiritualità e solidarietà che si manifesta nei devoti. Lascia pazientemente che il padre compia tutti i dovuti riti devozionali e rimane in disparte attento e pensieroso ad attenderlo. Ma il vecchio non compare piú. Reda lo cerca e allora gli addetti al santuario lo guidano verso i sotterranei del tempio dove vengono allineati i corpi di coloro che per stanchezza, malattia o vecchiaia sono morti dopo essere giunti alla meta. La ricerca è breve: Reda solleva un lenzuolo e sotto scopre il volto sereno del padre.
Esce quindi all’aria notevolmente sconvolto e commosso: la sua vita, prima distratta e fredda, è ora del tutto cambiata; la conversione del cuore appare iniziata; Reda non sarà piú quello di prima quando tornerà in famiglia.
I cortometraggi
Anche i cortometraggi sono veramente validi.
C’è un corto di un giovane regista egiziano che mi ha fatto piombare gradevolmente nell’atmosfera dei racconti boccacceschi del Decameron. Forse neppure conosce questo nostro autore medioevale Rami Abdul Jabbar, che in 15’ ci permette di assistere a quanto accade in una casa di un villaggio egiziano, dove vivono tre sorelle e la loro madre vedova. Non è giusto, le dicono, che tu ti sacrifichi e non possa riprenderti un marito, piacente e calorosa come sei; guarda: c’è un uomo di Dio che ha sí il difetto di essere cieco, ma è pure giovane e bello, dolce e sensibile, accoglilo tra le tue braccia come compagno per il resto della tua vita.
Prima riluttante, la donna infine accetta e si sposa. L’uomo è davvero tanto caro e dolce oltre che bello, per cui anche i cuori delle sorelle si infiammano e stimolano la loro mente creativa a trovare una soluzione che le soddisfi. Per cui, ognuna per conto proprio, con divertenti stratagemmi, si unisce a lui sotto le lenzuola, egli inconsapevole e soddisfatto per il grande affetto che, secondo lui, gli regala la legittima sposa. Si ride e non ci si scandalizza, perché l’immagine non è violenta e sfacciata e davvero il clima boccaccesco è rispettato nella sostanza affettiva e burlesca piú che nell’esibizione sessuale. Questo film si chiama Beit Min Laham che si traduce con Casa di carne, magari il solo titolo, però, è un po’ truculento.
Dall’Egitto alla Tunisia il passo è breve, solo che cadiamo nel tragico, stupefacente tragico a livello cinematografico, perché partiamo accanto a un gruppo di bambini che giocano sulla strada come tutti i bambini del mondo; 1…2…3…soleil si chiamano il gioco e il film, che dura solo 4’, perché arriva qualcosa di estraneo e di stridente sopra quei bambini, noi udiamo solo il rombo acuto di un aereo e dopo un istante quei corpi vivaci e allegri sono stesi insanguinati sul terreno in un mortale silenzio. È una donna a farci soffrire, Imen Nafti, ma vedremo che saranno ancora altre donne sudafricane, tunisine, algerine e marocchine a non lasciarci in pace con i loro tragici o drammatici racconti che attingono dal clima instaurato dal terrorismo, dalla guerra, dall’emigrazione e dalla sorda tradizione che schiavizza, dalle storie di bambini.
Prendiamo per esempio il marocchino Amal di Ali Benkirane, 17’ di piacevole e serena atmosfera tra scuola e famiglia di un bambino e di sua sorella Amal, che da grande vuol fare il medico incoraggiata pure dal maestro di scuola. La sua gioia e il suo sogno durano però poco, perché il padre pensa che solo i maschi possano avere un futuro anche lontano dalla casa e non certo le donne, che alla casa e solo ad essa devono dare tutto se stesse. E la tradizione continua…
Altra donna, giovane e bella, capace pure di esprimersi in buon italiano, è Meriem Riveill, tunisina nata ad Algeri. Il suo breve film si intitola Les Beaux Jours, 12’ di dolce malinconia dovuta al distacco di due sorelle, una delle quali, partita tanti anni prima per la Francia, rimasta vedova e sola, vive di dolci rimembranze che la riportano ai giochi e alle conversazioni dell’adolescenza.
Il connazionale Nejib Belkadhi con Tsawer (fotografie), dimostra di possedere dimestichezza col linguaggio cinematografico, che utilizza in modo innovativo e scattante con cui agisce attraverso le immagini, raccontando l’amore finito da parte di una donna che ora sta per sposarsi con un altro. Anche dalle fotografie è bene liberarsi, ma la cosa è piú complicata di quello che sembra.
Cito ancora un «corto» di un importante cineasta algerino, Rachid Bouchareb, che ci riporta con un disegno animato in bianco e nero ad una tragedia storica dell’immediato dopoguerra in Africa. Racconta ciò che con un lungo film già ci aveva mostrato il decano del cinema africano Sémbène Ousmane, l’eccidio dei soldati africani che chiedevano il giusto salario ai francesi che li avevano arruolati per combattere in Europa. Il film di Ousmane si chiamava Camp de Thiaroye, questo cortometraggio di 8’ si chiama L’ami Y’a bon, che traduciamo con L’amico coloniale.
Africa Subsahariana
Dyana Gaye, bella e nera come la pece, senegalese d’origine, è una giovane regista che ci conduce per le strade di Dakar tra i bambini della scuola coranica costretti dal marabutto a chiedere per lui l’elemosina tra la gente. Deweneti, titolo del film e nome di uno di questi ragazzini, è simpatico, creativo, spiritoso e dotato di una bella vivacità spirituale, che lo porta spontaneamente ad amare e ad aiutare a modo suo quelli che gli danno qualche centesimo (v. la lettura di Cola in Edav n. 350, p. 16).
La sudafricana Lara Foot Newton ci fa ripiombare assieme al suo co-regista Gerhard Marx, in una storia truce e maledettamente «normale» di sofferenza universale: la violenza sui bambini anche piccolissimi come Baby Tshepang: nove mesi, stuprata, uccisa. Come fanno i due registi a raccontare una storia cosí ributtante senza offendere la dignità loro e nostra e senza strumentalizzarla a fini spettacolari? Girano And There in the Dust (Laggiú nella polvere) in bianco e nero, con la tecnica dell’animazione, l’animazione tridimensionale di oggetti e una voce sconvolta del narratore che, sgomento, racconta.
Immagini e emozioni non da poco nel film Delwende, Leve toi et marche (Delwende, alzati e cammina) di Pierre Yaméogo del Burkina Faso. La storia sa molto di documentaristico nel contenuto, perché il regista ci introduce nelle comunità dove vengono ospitate in condizioni miserrime le donne ritenute streghe e che si trovano al centro della capitale Ouagadougou, povere donne cacciate dai loro villaggi perché ritenute malefiche e procacciatrici di sventura per tutti.
Anche L’appel des arènes (il richiamo delle arene) è un film piacevole; viene dal Senegal ed è di Cheick N’Diaye e narra dello sport nazionale della lotta immerso però in un clima di ambiguità e di violenza che circonda gli stadi e si sparge tra case e locali notturni, dove lo sport corre il rischio di guastarsi quando si vorrebbe che venisse a patti con comportamenti disordinati e attività criminali.
Un film su Hutu e Tutsi della regista del Burkina Faso Fanta Regina Nacro è un lavoro drammatico assai interessante, sullo stesso tema del film che ho introdotto nel capitolo della diaspora e che è di Raoul Peck. Due film diversi nella narrazione ma efficaci comunque. Infatti questo serio lavoro di Fanta Regina Nacro ha lo svolgimento di un dramma senza che mai compaiano nomi di personaggi e luoghi reali. Tuttavia l’impersonalità dell’ambientazione non attenua la drammaticità e la partecipazione emotiva alla storia che decisamente lascia intendere essere quella dei massacri vergognosi del Ruanda e del Congo.
Il fatto che tutto in questo film sia invenzione, amplifica, se vogliamo, il suo messaggio, che diventa palesemente un messaggio di perdono, di concordia e di pace solidale dopo il riconoscimento reciproco delle colpe per i delitti perpetrati. La figura del mentecatto, a cui è affidato il compito di cantore e di profeta di orrore, sottolinea la storia. Essa narra dell’incontro finalmente possibile tra il Presidente e il suo Colonnello ribelle e dei rispettivi seguaci. La pace e la concordia sembrano ad un palmo di mano. Ma ci vuole saldezza, vero pentimento e convinzione per mantenere i buoni propositi.
Questi sono messi in grave pericolo dal sospetto e soprattutto dall’odio e dal desiderio di vendetta inestinguibili che riempiono i cuori di alcuni e anche della moglie del Presidente: la donna nel corso dei massacri ha perduto il figlioletto, barbaramente sgozzato e anche deturpato nel suo corpicino dagli avversari.
Durante la festa della riconciliazione la Presidentessa riesce finalmente ad avere la confessione dello stesso Colonnello, che con profonda angoscia si dichiara colpevole dell’insensato delitto. Ecco allora partire l’azione di vendetta che mette a repentaglio la pace che si sta restaurando con estrema tensione e difficoltà: il Colonnello viene legato, torturato e bruciato vivo dai soldati fedeli alla Presidentessa. Ognuno corre a riprendere le armi, ma il Presidente, con un atto di coraggiosa decisione, afferra un fucile e spara sulla moglie fermando cosí la reazione della parte che stava tornando avversa a lui.
La pace è salva: questa la conclusione del film e l’auspicio dell’autrice del dramma, che lascia al mentecatto cantore di malefíci la conclusione: spegnere gli odi, non alimentarli con fantasie e supposizioni popolari, non affidare la verità al pettegolezzo e alla creazione fantasiosa di mostri.
Un film esemplare - Daratt (stagione secca)
Mahamat-Saleh Haroun, regista del Ciad, è al suo secondo film importante. Con ambedue è stato presente anche alla Mostra del Cinema di Venezia e tutti e due hanno vinto un importante premio. Il primo film del 2003 era intitolato By By Africa!
È ritornato a Venezia nel 2006 e a Milano nel 2007 con un film ancor piú impegnato e dolente e tuttavia assai costruttivo sul piano etico e dei valori..
Il Paese soffre della piaga, non rara in Africa, della guerra fratricida: la guerra civile va avanti dal 1965 e come tutte le guerre del genere ha provocato ingiustizie e vittime.
Ora il governo ha emanato una legge con cui dà l’amnistia ai criminali di guerra allo scopo annunciato di mettere a tacere odio, violenza e spirito di vendetta.
La reazione popolare però è di profondo scontento.
Su questo scenario si muove la vicenda di Atim, un sedicenne a cui è stato ucciso il padre.
Il nonno allora gli impone di recarsi a cercare il criminale e di fare giustizia. Gli mette in mano una pistola che conservava nascosta in un cassetto e lo incita alla vendetta. Lui non può farlo perché è cieco.
Atin parte e trova in un villaggio tracce del criminale. Nassara, però, ha cambiato vita e modo di pensare; forse è del tutto pentito di quanto ha fatto.
Il giovane fa in modo di entrare in contatto con lui; egli è panettiere, fa vita tranquilla, si è sposato con una giovane donna, ogni giorno esce dal panificio e distribuisce pane ai poveri del quartiere.
Atin si fa assumere e gli sta sempre vicino, pronto a cogliere il momento giusto per la vendetta. Intanto però viene a conoscere quell’uomo, che certamente gli ripugna, ma che nello stesso tempo lo attrae, forse vedendolo come un padre che egli non ha avuto.
Nassara gli si affeziona, gli insegna il mestiere, e un giorno decide di proporre al ragazzo di adottarlo e quindi di lasciargli in eredità il forno. Forse intuisce le intenzioni di Atin, anche perché un giorno scopre, e subito la fa sparire, la pistola del ragazzo.
Ma si fida di lui, al punto da fargli vedere un piccolo arsenale che tiene in un armadio, che può sempre servire in caso di necessaria difesa in quel clima di guerra e di odio.
Nassara un giorno gli propone di partire e di andare al suo villaggio e incontrare il nonno per chiedergli il permesso per l’adozione.
L’incontro tra Atrin, il nonno e Nassara avviene fuori del villaggio, nella savana. Il nonno, cieco, chiede se ha compiuto la missione per cui l’aveva fatto andar via da casa. Atin gli risponde che l’assassino del padre è con lui. Il nonno quindi gli impone di fare giustizia.
Il giovane fa spogliare Nassara, che ormai ha capito senza dubbio, lo fa inginocchiare e, in attesa del colpo di pistola, prega nella convinzione che fra poco morirà.
Il giovane spara in aria e il nonno gli chiede: non ha tremato, vero, la tua mano? Dagli ora il colpo di grazia. Atin spara ancora in aria e il nonno, soddisfatto, ritorna al villaggio accompagnato dal nipote.
Una storia che potrebbe essere vera, ma che certamente è un progetto necessario: occorre giungere al perdono, pur sofferto, e non continuare nella scia di sangue e di violenza. Un perdono che vuole però il pentimento del criminale, ma soprattutto un percorso di maturazione nella sofferenza e nella rinuncia da parte dell’offeso per poter giungere al risultato presentato dalla storia.
Un film, quindi, di grande impegno civile etico e religioso, in cui realisticamente si vede quanto questa strada è quasi sempre impercorribile dagli adulti impregnati di rancore e di rabbia causata dal dolore e dall’offesa patiti, ma quanto invece un giovane possa cogliere e capire, pur con grande fatica, il grande valore del perdono, egli piú scevro da incrostazioni e da falsi valori legati a concetti di dignità e di onore offesi.
Quindi un ottimo film, un concreto invito al perdono, un perdono non politico, non un indulto o un’amnistia di legge, ma un perdono che passa sofferto e pieno di contraddizioni e di difficoltà attraverso la maturazione, l’esperienza, una lunga via crucis per accettarne il valore e il contenuto da parte dell’offeso che si trova nella condizione di chiedere personalmente giustizia nei riguardi del criminale che gli ha ucciso il padre.
Per quanto ne so, Daratt è il secondo film realizzato da un musulmano che vorrei definire «catechistico» e valido non per questa o quella religione, ma universalmente, per tutti gli uomini, per un’umanità che deve invertire strada, rivedere alcuni concetti di giustizia, che deve imparare a perdonare. E questo è il messaggio piú forte, per esempio, del cristianesimo (v. anche la lettura di Brugnoli in Edav n. 343, p. 10).
Dicevo: il secondo film «catechistico»; l’altro è quello di cui ho parlato sopra, del giovane marocchino che ha realizzato Viaggio alla Mecca, che sugli schermi italiani è comparso col titoloIl Grande Viaggio grazie all’impegno dell’Istituto Luce. Pure esso mostra il percorso di maturazione di un adolescente costretto ad accompagnare il nonno al pellegrinaggio, che per lui non ha nessun significato. Il nonno, pur nel silenzio del suo comportamento, gli insegna a conoscere l’uomo, i valori della religione, la solidarietà, il valore della carità e della comprensione. Il pellegrinaggio alla Mecca non voluto dal giovane si rivelerà uno stimolo, pur profondamente sofferto, di crescita umana e morale.
L’Africa della Diaspora
Un gioiello dell’animazione - L’arbre aux ésprits
A me è piaciuto molto L’arbre aux ésprits(L’albero degli spiriti) di Cilia Sawadogo. Il nome della regista ci riporta in Africa, in Burkina Faso. In realtà la sua pelle è nera a metà, perché ha madre tedesca e vive e lavora in Canadà, ma si occupa nella sua professione di insegnante universitaria, di preparare i registi d’Africa a realizzare opere di animazione come finora lei ha fatto.
Nel film mediometraggio di 45’, Cilia ci fa trovare i segni grafici e l’ispirazione poetica e ecologistica di due grandi autori del cinema, Gaston J.-M. Kaboré cineasta del Burkina e Michel Ocelot francese ma formatosi nel gusto e nella sensibilità artistica in Guinea dove visse parecchi anni della sua infanzia e della adolescenza.
È in particolare Rabiche voglio ricordare di Gaston eKirikudi Michel. Il primo è un omaggio alla semplicità e all’ecologia dello spirito attraverso il racconto che parla di un bambino burkinabé e della sua tartaruga; il secondo è una festa di colore e di invenzione fiabesca per dire piuttosto di problemi etici e sociali di cui soffre l’umanità, la donna in particolare.
Ne L’albero degli spiriti si riconosce la mano, forse meno ricca e vivace di colore ma certamente assai efficace nel raccontare una fiaba di denuncia, di Ocelot e si respira la poesia e la sensibilità umana del regista africano. Due elementi che rendono grande e importante questo piccolo film d’animazione realizzato con l’essenziale dei mezzi tecnici necessari.
Esso narra di due fratelli che in Africa vanno verso un grosso baobab e in esso e dentro di esso si perdono. Scoprono che sta morendo: non ha acqua che arrivi alle sua radici, qualcuno la ruba prima che possa riportare vita alla vegetazione. È un mostro a farlo aiutato dai suoi succubi schiavetti, un mostro moderno e agguerrito che intende far commercio del bene fondamentale e necessario alla vita di tutti e non solo di chi può comprare l’acqua che egli imprigiona.
Kodou e Tano, i due fratellini, troveranno aiuto nel mondo degli antenati, la cui porta d’accesso si trova sotto le radici del grande baobab; l’attraversano e arriveranno cosí a convincere gli avi che è necessario intervenire prima che tutto muoia.
È veramente da augurarsi che questo delizioso film d’animazione possa essere divulgato anche fuori dei confini del Canada per tutti gli elementi educativi e estetici che contiene.
Lo scenario è quello dell’Africa centrale nera, in cui è ambientato un film sulla guerra disastrosa tra Hutu e Tutsi in Ruanda.
È un potente e assai coraggioso film di un autore affermato (non in Italia, sí nel resto del mondo!) di nome Raoul Peck, un nero d’origine africana che vive a Haiti e che da anni sta realizzando film di grande impatto emotivo e nello stesso tempo assai efficaci sul piano della ricostruzione storica di vicende e di personaggi africani e anche della stessa isola di Haiti.
Il film Qualche volta in aprilesi svolge in Ruanda, dove è girato tornando sugli stessi luoghi dei massacri di centinaia di migliaia di Hutu nel 1994. Mette cosí in scena con cuore pudico gli stessi reali personaggi delle vicende vissute. Il film narra con straordinaria intensità storie di persone sulle cui vicende s’intreccia la dolente trama di fondo, in realtà assai evidente, di quanto è accaduto e ancora sta accadendo in quelle paradisiache terre, se non fosse per la inimmaginabile crudeltà degli uomini.
La storia si costruisce intorno ad un capitano dell’esercito e della sua famiglia, che ora sono in pericolo perché appartengono all’etnia diversa da quella dei dominatori Tutsi. Amici, vicini di casa, ufficiali, giornalisti, sacerdoti sono dentro alla storia e soprattutto il popolo delle due etnie che fino a poco prima convivevano e prosperavano civilmente ed economicamente. Poi d’improvviso (ma quanto sono estranei alcuni Paesi dell’Europa che hanno interessi da proteggere, l’incapacità a percepire la gravità dei fatti da parte degli Stati Uniti e l’inefficienza totale dell’ONU?) eccoli armarsi di fucili e «machete» forniti a centinaia di migliaia dalla Cina e iniziare la carneficina che ha fatto quasi un milione di morti.
Il film segue tutti questi fatti da dentro, immerso emotivamente nella disperazione di un popolo, nelle paure, nei tradimenti, nell’orgia di inumanità incomprensibile che ha coperto fiumi e laghi di cadaveri, di epidemie e di angoscia.
Altri film di questo autore, importantissimi per conoscere i mali del mondo (e l’ignoranza di essi non ci aiuta a vivere meglio), L’uomo del porto sulla feroce dittatura haitiana e i suoi due Lumumba, sul presidente congolese trucidato perché voleva una vera autonomia dai popoli europei (Francia e Belgio). Il C.O.E. associazione ONG di Milano, ha dato il suo apporto alla conoscenza dei tristi fenomeni del male dilagante nel mondo mettendo in distribuzione il primo di questi due film su Lumumba, Lumumba, la morte di un profeta del 1991 e L’uomo del porto del 1993.